La lotta alla deforestazione può attendere: l’Unione europea rinvia l’Eudr
La tutela delle foreste richiede regole efficaci, ma i nuovi rinvii all’Eudr fanno temere per il futuro anche delle foreste più antiche d’Europa
Garantire una maggiore efficienza del sistema informatico e semplificare gli obblighi per micro e piccoli operatori primari nei Paesi a basso rischio: sono questi gli obiettivi indicati dal Regolamento noto come Eu Deforestation Regulation (Eudr). Cioè la normativa contro la deforestazione e a tutela della biodiversità con cui si punta a garantire che i prodotti immessi sul mercato europeo non contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo.
Secondo le stime della Fao, tra il 1990 e il 2020, 420 milioni di ettari di foreste – una superficie più grande dell’Unione europea – sono andati perduti a causa della deforestazione. Sull’imprescindibile importanza degli ecosistemi forestali sulla Terra c’è una consapevolezza diffusa. In un recente sondaggio condotto da Greenpeace in 17 Paesi del mondo, ben l’86% degli intervistati ritiene che la protezione delle foreste sia fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici.
Un nuovo rinvio per l’Eudr: la lotta alla deforestazione si allontana
Per l’Eudr non si tratta della prima battuta d’arresto nel suo accidentato iter di attuazione. Dopo l’entrata in vigore a giugno 2023, l’Unione europea aveva già concesso, a dicembre dello stesso anno, un periodo di transizione di dodici mesi. In base a quelle scadenze, il regolamento avrebbe dovuto applicarsi dal 30 dicembre 2025 per le medie e grandi imprese, e dal 30 giugno 2026 per le micro e piccole. Un ulteriore rinvio di dodici mesi era stato ipotizzato lo scorso 23 settembre, con la motivazione di dover rafforzare il sistema informatico.
A fine ottobre è arrivata la conferma ufficiale. Il rinvio sarà di sei mesi, fino al 30 dicembre 2026, ma solo per le micro e piccole imprese. Per le grandi e medie, invece, resta la scadenza del 30 dicembre 2025. Con un periodo di tolleranza di sei mesi per l’applicazione e i controlli. «Temo che dietro questo rinvio ci sia la volontà di prendere tempo e rendere più blanda la normativa», commenta a Valori.it Giorgio Vacchiano, docente in gestione e pianificazione forestale all’Università Statale di Milano.
Le conseguenze del rinvio: tra costi più alti e controlli incerti
Le conseguenze dell’Eudr si ripercuoteranno su diversi settori dell’economia mondiale: dall’industria della carne a quella del caffè, dai produttori di cacao a quelli di legname. Finendo a cascata sugli stessi consumatori che pagheranno a prezzi più alti il prodotto finito. Tra le principali criticità del nuovo regolamento, Vacchiano evidenzia soprattutto la difficoltà di definire in modo chiaro il monitoraggio del degrado forestale. Anche perché se «la deforestazione è ben visibile con i rilievi satellitari, non si può dire altrettanto del degrado forestale».
In attesa che il sistema informatico venga pienamente adeguato, la Commissione ha previsto alcune misure di semplificazione. Per esempio, l’esclusione per operatori e commercianti a valle dall’obbligo di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza, che resterebbe solo per chi immette per primo i prodotti sul mercato. In questo modo, «sarà necessaria una sola presentazione nel sistema informatico dell’Eudr al punto di ingresso sul mercato per l’intera catena di approvvigionamento», si legge nel comunicato. Nelle prossime settimane spetterà al Parlamento europeo e al Consiglio discutere la proposta della Commissione. E adottare formalmente le modifiche entro la fine dell’anno, in tempo per le prime scadenze fissate per le imprese.
Le foreste più antiche d’Europa sotto pressione
L’attuazione dell’Eudr interessa anche le foreste europee, come quelle della regione dei Carpazi, tra le più antiche del continente. Le foreste custodiscono spesso una preziosa memoria storica. In Romania, la distribuzione attuale delle classi di età delle foreste è fortemente sbilanciata, con una prevalenza di ecosistemi giovani. Questa situazione deriva dal processo di restituzione delle terre dopo il periodo comunista, quando circa un milione di ettari di foreste furono assegnati a oltre 700 mila proprietari privati, liberi di scegliere le aree che preferivano. Di conseguenza, le vecchie foreste sfruttabili, che fornivano il maggior volume di legname, sono state le più richieste. In meno di trent’anni, la maggior parte di esse è stata già sfruttata legalmente e illegalmente.
«In Romania, la discussione sulla protezione delle foreste primarie è iniziata circa vent’anni fa. Al momento circa 80mila ettari di foreste primarie sono state riconosciute a livello nazionale. Ma è un valore sottostimato», spiega Valentin Sălăgeanu, responsabile della campagna foreste di Greenpeace CEE Romania. «Dal 2001 si è assistito a un aumento delle attività di taglio, anche illegale, con un picco tra il 2008 e il 2012. Di conseguenza, molte foreste sono state gravemente degradate».
In Europa non si può quasi più parlare di foreste primordiali. Esse rappresentano appena il 2% del patrimonio forestale complessivo. E non tutte le foreste rimaste possono essere considerate “vetuste”, cioè caratterizzate da grande varietà strutturale e funzionale, frutto di decenni o secoli di sviluppo naturale. Anche in Romania la classificazione è spesso fuorviante. Definire “vetuste” foreste di 120 anni è un errore. Si tratta di boschi ben gestiti, che grazie ai sistemi di rotazione a lungo termine adottati nel Paese assumono un aspetto simile a quello delle foreste secolari.
Il caso Ikea e i limiti delle certificazioni forestali
In un recente report di Greenpeace, si cita il caso di Rusca Montană, un ecosistema forestale antico che ha mantenuto la continuità dei processi naturali per secoli. Caratterizzata da una complessità strutturale e da una vasta gamma di classi di età degli alberi, Rusca Montană presenta anche alberi di oltre 180 anni. Secondo il piano di gestione forestale ufficiale, le foreste con alberi di questa età rappresentano meno dello 0,5% di tutti gli ecosistemi forestali della regione dei Carpazi in Romania. Ciò la rende ecologicamente rara e di importanza nazionale, eppure persino lì l’attività di taglio è stata riaperta. Il volume di estrazione previsto è di 4.200 m³, di cui una parte è già stata trasportata a Masifpanel, un fornitore di Ikea.
Seppure il colosso svedese operi entro i limiti di legge – questo l’argomento citato a propria difesa – la critica mossa da Greenpeace è contro questi vincoli normativi non abbastanza cautelativi del patrimonio forestale. La certificazione Fsc – di cui si fregia Ikea – dovrebbe attestare una gestione responsabile delle foreste, con monitoraggi regolari nel corso del tempo. «In Romania lo standard Fsc non viene aggiornato dal 2017 – contesta Greenpeace –. E non prevede la protezione integrale del 10% dei territori forestali, come stabilito dagli obiettivi europei di protezione della biodiversità».
Verso una gestione più scientifica e sostenibile delle foreste
«Gli standard Fsc non devono essere aggiornati ogni anno», commenta Vacchiano. «Si può invece ragionare sulla necessità di una loro maggiore accuratezza quando si parla di tutela della biodiversità. Non sono sufficienti delle indicazioni di massima. E in questo la scienza deve fare la sua parte. Con la Statale e l’università finlandese di Oulu stiamo sviluppando un progetto (FORbEST) che ha proprio questa ambizione: cartografare le foreste ad alta biodiversità in Europa e sviluppare delle linee guida per una gestione più attenta caso per caso».
Senza dubbio una foresta biodiversa “funziona” meglio come ecosistema, è più stabile agli stress climatici e produce di più. «La richiesta di risparmiare delle foreste che legalmente possono essere soggette a tagli commerciali è il punto di partenza di un dibattito interessante – conclude Vacchiano – perché ci pone davanti al paradosso di dare un’etichetta e porre dei confini a quello che in ecologia varia di continuo, come le foreste appunto. La vera sfida inizia dal porsi le domande giuste e non smettere di farlo».


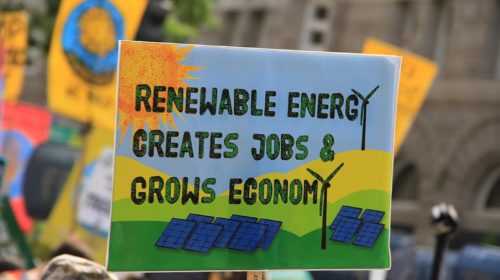

Nessun commento finora.