Cop29, e se finanziassimo la transizione ecologica con le tasse sui ricchi?
Alla Cop29 si discute di finanza. Quanti soldi andranno dal Nord al Sud globale? E soprattutto, è possibile prenderli a chi ne ha fin troppi?
A Baku, oggi Azerbaigian ma allora parte dell’Impero Russo, nel 1848 venne estratto il primo barile di petrolio. Non sembra però che il Paese abbia voglia di estrarre l’ultimo e chiudere i pozzi. «Il gas e il petrolio sono regali di Dio», ha dichiarato il presidente azero Ilham Aliyev nel suo discorso alla Cop29, ospitata quest’anno nella sua capitale. Anche per questo la definizione di «Cop della finanza» che l’edizione corrente si è guadagnata non dispiace al governo organizzatore: permette di spostare l’attenzione dalla riduzione del fossile, e di rimandare qualunque discussione sulle emissioni all’anno prossimo – se pure accadrà. Non a caso il vertice si è aperto con un passo avanti non da poco sul mercato della CO2.
Quanti soldi servono per la transizione ecologica
La finanza climatica, però, è davvero un tema centrale. Lo è anche nella sua accezione più comune in sede di Nazioni Unite: flussi di denaro che dai paesi ricchi vanno al Sud globale per finanziare la transizione ecologica. È un dato di fatto che un grosso pezzo di umanità non abbia le risorse per investire su energia e infrastrutture verdi, a prescindere dalla volontà politica, e ancora meno per rimediare ai sempre più frequenti danni della crisi climatica. Sulla quantità necessaria esistono molte stime – la Climate Policy Initiative parla ad esempio di 10mila miliardi l’anno tra il 2030 e il 2050. Per questo COP29 è importante, più forse di quanto non sembri alle nostre latitudini.
Il principale obiettivo del summit in corso a Baku è il raggiungimento di un consenso sul New Collective Quantified Goal (NCQG). Fuori dal burocratese dei negoziati, si tratta della cifra che i Paesi industrializzati promettono di stanziare in favore delle nazioni cosiddette in via di sviluppo. Un modo per rimediare almeno in parte alle emissioni rilasciate negli ultimi due secoli in larghissima parte da una ristretta cerchia di Stati. Nel 2009, una vita politica fa, si promisero 100 miliardi l’anno. Ma da subito emersero una serie di questioni. In primis, promettere non significa dare.
Segui tutti gli aggiornamenti

Diretta | Copcast, il diario della Cop29 di Baku
Tutte le notizie in diretta dalla Cop29 sul clima di Baku. E un podcast quotidiano per rimanere aggiornati
Chi dovrà pagare per la transizione
I 100 miliardi sono stati raggiunti davvero solo nel 2022 – si era concordato la linea rossa fosse il 2020– e con enormi difficoltà. Poi c’è la questione dell’uso: non esiste una definizione univoca di finanza climatica, e men che meno un’organo unico e autorevole che controlli la destinazione dei fondi. I casi di mala gestione – o direttamente di investimenti suppostamente verdi finiti su fossile e cementificazione – non si contano. Infine c’è la qualità dei fondi. Una parte importante del denaro arriva al Sud globale sotto forma di prestiti – di solito a tassi agevolati, ma comunque nuovi fardelli per paesi spesso già terribilmente indebitati.
Alla Cop29 il primo punto da chiarire sarà il quantum. Alcuni pezzi da novanta del G77 – l’alleanza che include la gran parte dei Paesi africani, latinoamericani e asiatici – chiedono di decuplicare la stima del 2009: mille miliardi l’anno. Il Nord globale si oppone, e risponde con la necessità di allargare la platea dei donatori. Il dito è puntato sulla Cina: Pechino è favorevole ad accordi ambiziosi sulla finanza climatica, ma non intende contribuirvi economicamente.
La Cina è ancora classificata come Paese in via di sviluppo in sede di Convenzione Onu sui cambiamenti climatici, e come tale non ritiene di dover essere inclusa nella lista di coloro che dovranno aprire il borsellino. Stati Uniti e alleati – Europa, Regno Unito, Giappone, Svizzera – ritengono invece che il suo ruolo di seconda economia mondiale e primo emettitore assoluto le imponga di partecipare. Altro punto dolente è l’origine dei fondi – evidentemente legata al quanto. I paesi ricchi sperano di attingere il meno possibile dai propri bilanci, e invitano piuttosto a mobilitare risorse private tramite meccanismi di mercato. Perché questa sia l’opzione preferita delle capitali occidentali è chiaro, ma non aiuta a risolvere il problema principale: un investitore privato deve guadagnare dal suo investimento, prima che contribuire alla decarbonizzazione o allo sviluppo di una nazione in difficoltà.
La proposta di Francia, Kenya e Barbados arrivata a pochi giorni dalla Cop29
Proprio su questo si è sviluppato, dentro e fuori dai negoziati, un dibattito interessante. Ad aprirlo sono stati pochi giorni fa i presidenti di Francia, Kenya e Barbados. I tre Paesi dirigono un gruppo di lavoro dedicato alla finanza climatica, e in un articolo di pochi giorni fa i loro capi di governo – Emmanuel Macron, Mia Amor Mottley e William Ruto – propongono di usare una serie di strumenti già esistenti, aumentandone la portata. In particolare, si parla di un mix di tasse sulle transazioni finanziarie, sul trasporto marittimo e aereo, sulle emissioni. Proposte che hanno in parte l’appoggio della comunità internazionale: dal palco di Baku il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è espresso a favore di tassare navi e aerei.
Certo, il consenso e la volontà politica per alcune di queste misure sembrano mancare. Mentre altre, basate su meccanismi di mercato e debiti, hanno mostrato in passato tutti i loro limiti. Eppure i soldi ci sono, e si potrebbero prendere. Come ricorda l’ong Climate Action Network, una tassa mondiale sulla ricchezza pari al 2% del patrimonio di 300o ultra-ricchi produrrebbe 250 miliardi l’anno. Il G20 discute da tempo di una proposta simile. Ma la resistenza di chi quel denaro lo possiede non è ancora stata abattuta.

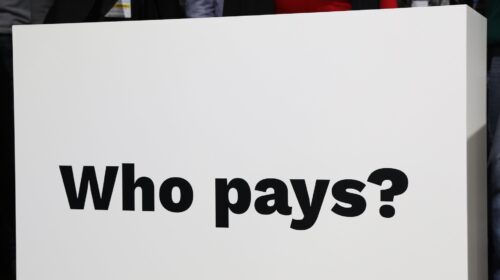


Nessun commento finora.