Dietro una felpa (green) di Zara: solo le briciole a chi la produce
Un'indagine Public Eye scompone il prezzo di una felpa (sostenibile) Join Life: noi paghiamo quasi 40 euro, a chi lo confeziona (tutti insieme) ne restano 2
Cari consumatori, siete avvisati. Se comprate una felpa di Zara solo pochi spiccioli di quanto avrete speso andranno a chi ha prodotto quel capo, con le sue mani e il suo lavoro. E parliamo in particolare – paradosso dei paradossi – di una maglia della collezione “Join Life”, la linea modello per la sostenibilità dell’azienda. La denuncia è il risultato di un’inchiesta, Following the tracks of a Zara hoody, pubblicata oggi e realizzata da Public Eye, Ong con sede a Zurigo che ha ripercorso a ritroso la produzione di un maglione “green” di Zara, mettendo in luce la realtà che vivono i lavoratori e le lavoratrici lungo la catena di fornitura.

Scomponendo il prezzo: ai lavoratori pochi centesimi
Pubblic Eye ha risalito la catena di produzione giungendo fino ad una fabbrica di Smirne (in Turchia), incaricata della realizzazione di 20mila capi, poi venduti al prezzo di 39,67 euro ciascuno (prezzo d’acquisto on line in Svizzera). Una cifra che è stata scomposta in tutte le sue parti da Le Basic e per la quale al marchio multinazionale del fast fashion – di proprietà del colosso spagnolo Inditex – ritornano 4,20 euro.
Non un granché, potrete pensare. Ma solo prima di sapere che alla fabbrica tessile turca, che svolge i processi di taglio del materiale, cucitura, imballaggio e aggiunta delle etichette, arrivano 1 euro e 53 centesimi al pezzo, e che, guardando solo ai valori assoluti, ci sono altri ingranaggi della filiera ancor meno privilegiati. Alla raccolta del cotone indiano vanno solo 26 centesimi di euro, per la separazione delle fibre dai semi ne restano 42, mentre la stamperia che ha apposto lo slogan in due punti sull’indumento incamera 17 centesimi per ogni felpa.
Zara lancia la campagna “Respect”, ma non rispetta i suoi lavoratori
Un problema di numeri risicati, quindi, ma non solo. E lo si capisce leggendo il commento della Campagna Abiti Puliti (sezione italiana di Clean Clothes Campaign). In una nota gli attivisti sottolineano che «Inditex si presenta al pubblico come un’azienda trasparente, che attribuisce la massima importanza alle persone che realizzano i suoi capi. Lo slogan della sua campagna di comunicazione, “R-E-S-P-E-C-T: find out what it means to me” (“RISPETTO: scopri cosa significa per me“), in riferimento alla canzone di Aretha Franklin, sottintende la cura che l’azienda avrebbe verso le lavoratrici e i lavoratori della sua filiera».
Ed è perciò che la ripartizione del prezzo genera interrogativi e sconcerto. Dal momento che, a fronte dei profitti che la multinazionale acquisisce per la felpa venduta (i già citati 4,20 euro, che generano 3,97 euro di utile netto), il totale dei costi attribuibili alla manodopera si ferma a soli 2,08 euro per capo.
Una miseria se pensate che la multinazionale iberica ha registrato un utile netto record di 3,44 miliardi di euro nel 2018, vendendo 1 miliardo 597 milioni e 260mila capi di abbigliamento (per 26 miliardi di euro). E che quello oggetto di indagine porta il marchio di Zara, il maggiore del gruppo, che l’anno scorso rappresentava oltre il 70% delle vendite. Senza dimenticare poi che quanto viene corrisposto all’impresa fornitrice, prima di diventare salario per gli operai, viene decurtato dei costi di fabbrica e dei profitti dei titolari.
La ricerca stima perciò che ogni operaio turco riceva circa 1 euro e 10 centesimi per capo, su cui avrà ancora le tasse da pagare.
Insomma, ai lavoratori resta davvero poco. Il che, va detto, non è incoerente con l’accezione del termine “sostenibile” cui si fa riferimento sulla prima pagina della collezione Join Life, dove si parla di sostenibilità ambientale ma mai si cita quella sociale. Né si esaltano impegni particolari in tema di diritti dei lavoratori, condizioni di sicurezza, parità di genere o salari.
Salari a meno di 4 euro dalla sussistenza
Eppure Public Eye sottolinea che, affinché i lavoratori in Turchia e in India coinvolti nella produzione di quelle felpe siano in grado di «sopravvivere coi loro salari, la retribuzione dovrebbe essere moltiplicata per un fattore di 1,9 – 3 a seconda della fase di produzione». E con ciò la differenza di prezzo in più per ogni capo equivarrebbe solo a 3,62 euro. Comunque meno di quanto ci guadagna Inditex.

Uno sforzo che non pare davvero ingestibile per una corporation come Inditex, sulla quale arriva anche la stoccata di Abiti Puliti, ricordando che «Per garantire la produzione è evidente che i proprietari siano stati costretti a sottopagare i dipendenti o a farli lavorare più del consentito. I lavoratori avrebbero guadagnato tra i 310 e i 390 euro al mese, circa un terzo del salario stimato dalla Clean Clothes Campaign come dignitoso».
In conclusione Public Eye sostiene infatti che, con salari compresi tra 2.000 e 2.500 lire turche mensili, che è il salario minimo legale o poco più, i lavoratori che realizzano la felpa con cappuccio con lo slogan Respect stampigliato sopra rimangono ben lontani dal percepire un salario di sussistenza.
Motivo per cui Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti, individua come necessario adottare «accordi vincolanti che obblighino i marchi committenti a pagare prezzi adeguati». Contro la compressione dei costi verso i fornitori e l’impoverimento cronico di milioni di lavoratori nel mondo.
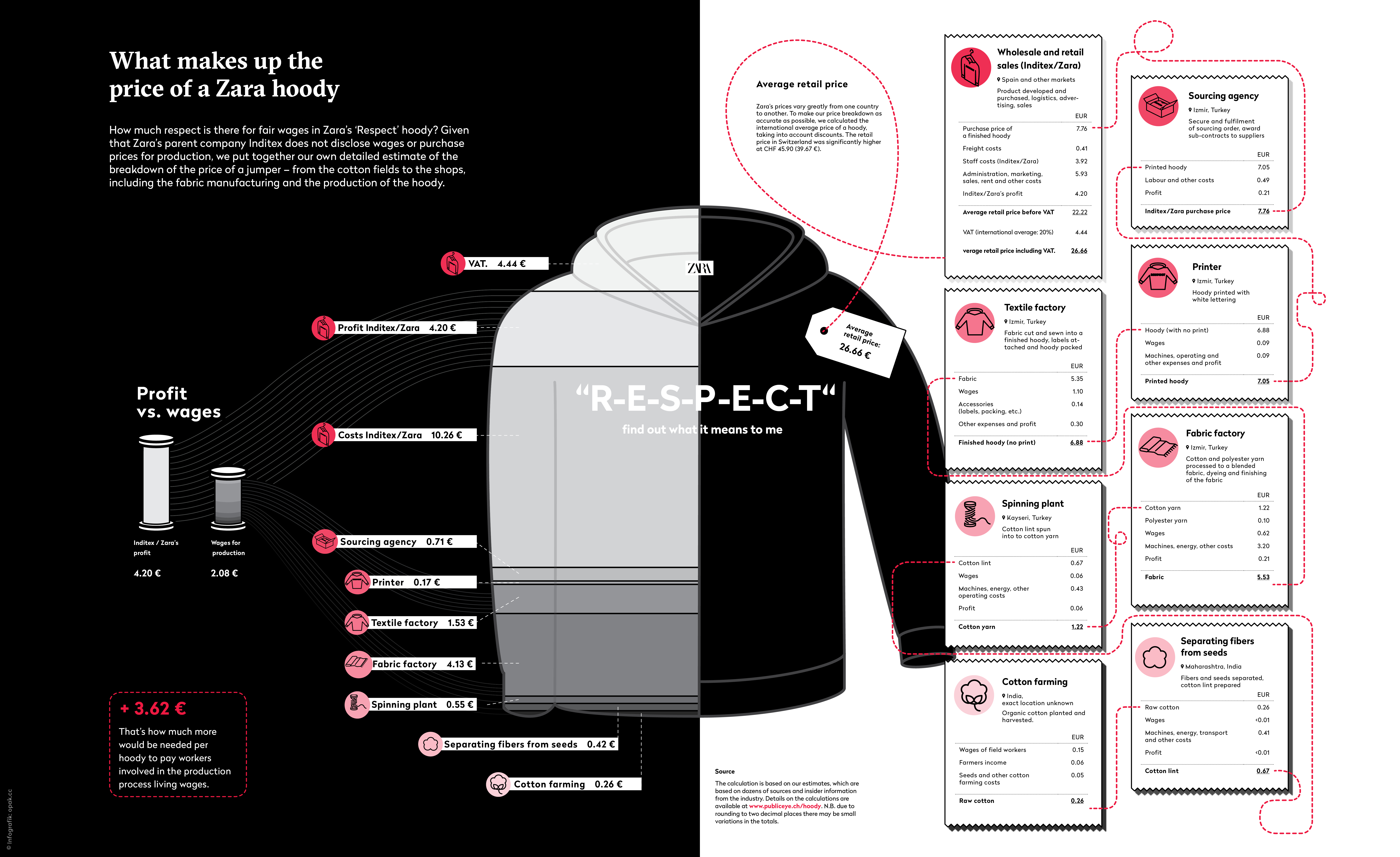




Nessun commento finora.