Clima. I piani di adattamento sono pronti, manca all’appello la finanza
Per l’adattamento alla crisi climatica servono oltre 300 miliardi di dollari l’anno, nel 2023 ne sono arrivati 26. Lo riferisce l’Onu in vista della Cop30
Le nazioni industrializzate e gli investitori privati stanno perdendo tempo. Stanno perdendo tempo perché è comprovato, senza alcun margine di dubbio, che la crisi climatica sta provocando impatti sempre più gravi sulle persone, sui territori e sui sistemi economici. È altrettanto comprovato come esistano misure capaci di limitare i danni. Ma i flussi finanziari destinati a queste politiche di adattamento sono enormemente più bassi rispetto a quanto sarebbe necessario. E anche rispetto a quanto è stato messo nero su bianco alle Conferenze sul clima.
L’Adaptation Gap Report pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) a fine ottobre, in vista della Cop30 di Belém, non usa più mezzi termini per denunciare questo abisso tra dichiarazioni e fatti. Dicendo chiaro e tondo, fin dal titolo, che «il mondo si prepara alla resilienza climatica – ma senza i soldi per arrivarci».
Finanza per l’adattamento: le cifre promesse e quelle stanziate
Veniamo quindi ai numeri. Se si guarda ai costi modellizzati, cioè alle simulazioni basate su scenari economici e climatici, i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di 310 miliardi di dollari all’anno per l’adattamento entro il 2035. Se ci si affida invece alle dichiarazioni ufficiali che i loro governi hanno fatto attraverso i piani climatici nazionali (nationally determined contributions, Ndc) e i piani di adattamento, la stima sale a 365 miliardi di dollari l’anno, sempre entro il 2035. Nel 2023 i flussi di finanza pubblica internazionale destinati all’adattamento nei Paesi in via di sviluppo ammontavano a 26 miliardi di dollari. Cioè da 12 a 14 volte in meno rispetto a quanto necessario. Per giunta, la cifra è in calo: l’anno precedente ammontava a 28 miliardi.
Road to Belém: aiutaci a raccontare la Cop30
Nel 2025 la conferenza sul clima si terrà alle porte dell'Amazzonia. Vogliamo esserci per raccontarla con uno sguardo critico e indipendente. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Da Glasgow a Baku, gli impegni presi alle Cop
Che i flussi finanziari per il clima siano troppo bassi è noto. Quelli per l’adattamento, inoltre, sono briciole se paragonati a quelli per la mitigazione (cioè il taglio delle emissioni).
Già il Patto di Glasgow, approvato alla Cop26 del 2021, poneva l’obiettivo di raddoppiare entro il 2025 i fondi pubblici internazionali destinati all’adattamento nei Paesi in via di sviluppo. L’anno di riferimento è il 2019: all’epoca ammontavano a circa 20 miliardi di dollari. Considerato che nel 2023 erano a quota 26 miliardi e che da allora i Paesi donatori hanno ulteriormente tagliato gli aiuti pubblici allo sviluppo, è chiaro che quest’impegno sarà disatteso.
La Cop29 di Baku ha messo al centro proprio la finanza climatica, arrivando a definire il new collective quantified goal (Ncqg). Ma quest’ultimo è ben inferiore al fabbisogno reale, visto che ammonta a 300 miliardi di dollari l’anno (da qualsiasi fonte, pubblica e privata) e tiene insieme adattamento e mitigazione.
Che ruolo può avere il settore privato
Far crescere i flussi finanziari per l’adattamento è dunque una priorità, ma non conta solo il quanto. Il come e il chi sono altrettanto dirimenti. Il new collective quantified goal sottolinea la necessità di ricorrere a finanza agevolata (concessional). Effettivamente, nel biennio 2022-2023 circa il 70% della finanza pubblica internazionale per l’adattamento risponde a questa definizione. Ma è anche vero che il 58% del totale è stato erogato comunque sotto forma di prestiti. Per quanto una parte di essi preveda tassi inferiori a quelli di mercato, resta il fatto che i Paesi più vulnerabili si sono indebitati ulteriormente.
Di norma si dà per scontato che questi flussi finanziari siano pubblici. Secondo l’Adaptation Gap Report 2025, infatti, circa tre quarti delle attività di adattamento individuate nei piani nazionali e dalle Ndc sono finanziati dal settore pubblico. Questo per due motivi. Il primo è che si tratta di opere pubbliche, come dighe o barriere per proteggere dalle inondazioni. Il secondo è che interventi del genere sono difficili da monetizzare. Hanno ricadute sociali ed economiche enormi nel medio-lungo termine, ma i rendimenti finanziari nell’immediato sono tutt’altro che allettanti.
Ad oggi, i flussi finanziari privati si aggirano sui 5 miliardi di dollari l’anno e si focalizzano su ambiti come l’innovazione in agricoltura o la gestione delle risorse idriche. Realisticamente si può puntare a moltiplicare questa cifra per dieci entro il 2035, arrivando al 15-20% del totale. Questo a patto che il pubblico faccia da leva attraverso incentivi, garanzie e altri sistemi per ridurre il rischio.
I piani per l’adattamento ci sono: mancano i soldi per realizzarli
Volendo trovare una buona notizia nell’Adaptation Gap Report, ci sono grandi passi avanti in termini di pianificazione. Sui 197 Stati del Pianeta, ben 172 dispongono di un piano, una strategia o una politica nazionale di adattamento. Anche tra quelli che mancano all’appello, tutti (tranne quattro) hanno almeno iniziato a lavorare in questa direzione. Non è però scontato che questi piani siano efficaci, considerato che 36 di essi risultano obsoleti o non vengono aggiornati da almeno dieci anni.
Fa ben sperare, però, il fatto che il 59% dei Paesi abbia integrato almeno in parte l’adattamento all’interno di un piano o di una strategia nazionale non specificamente climatica. In gergo si parla di mainstreaming dell’adattamento. Ed è qui che si gioca la partita. Perché i piani servono a poco se restano sulle scrivanie dei ministeri dell’Ambiente: tornano davvero utili quando incidono sulle scelte economiche, agricole, sanitarie o infrastrutturali.

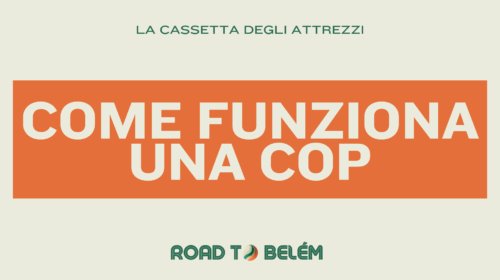


Nessun commento finora.