«Armi e guerre sono devastanti anche per economia e ambiente»
Martina Pignatti Morano, direttrice di Un Ponte Per, suggerisce come contrastare la narrazione bellicista: ad esempio con la finanza etica
Il tragico impatto in termini di vite umane viene prima di tutto. Ma la guerra, gli eserciti, il settore degli armamenti hanno anche un enorme impatto economico e ambientale. Su cui non ci si sofferma abbastanza. «È importante che le persone si informino, perché ci sono dati che dovrebbero smuovere l’opinione pubblica»: a dirlo è Martina Pignatti Morano, direttrice di Un Ponte Per, associazione nata nel 1991 dal movimento italiano per la pace che allora protestava contro la prima Guerra del Golfo. Attiva soprattutto in Medio Oriente, attraverso una rete di partner locali supporta la società civile in aree colpite da conflitti ambientali e occupazioni militari. «Integriamo l’azione umanitaria – dice Pignatti Morano, che è nel Comitato etico di Banca Etica – con la promozione dei diritti umani e dello sviluppo economico».
Oggi impera una narrazione bellicista: come lo spiega? E che reazione suscita in voi che ben conoscete l’impatto dei conflitti?
Con la guerra in Ucraina si è sviluppato un forte sentimento di solidarietà per un popolo attaccato e aggredito militarmente. Ma la stessa solidarietà sarebbe dovuta e dovrebbe continuare ad andare verso iracheni, palestinesi, curdi, cioè tutti i popoli soggetti ad attacchi o occupazioni militari. Nel caso dell’Ucraina, quel sentimento si è purtroppo convertito in una retorica bellicista che ha convinto buona parte dell’opinione pubblica, e larga parte della politica, che la soluzione fosse l’escalation militare: più aiuti militari, spese, produzione. Facendo così gli interessi dell’industria bellica. La spesa militare globale ha toccato nel 2023 il nuovo record di oltre 2.400 miliardi di dollari, +6,8% in termini reali sul 2022. E ciò in un momento in cui dovremmo concentrare le energie sulla transizione ecologica. Tutto ciò è terribile.

Cosa risponde a chi afferma che sostenere il settore bellico è, come dire, “cosa buona e giusta” in senso economico e sociale?
Dal punto di vista sociale, è oggettivamente difficile trovare qualcosa di più dannoso delle armi, che sono uno strumento di morte. In ogni conflitto, per giunta, è altissimo l’impatto sui civili, perché le armi che colpiscono solo i combattenti non esistono. Veniamo all’impatto economico, in termini ad esempio di risorse sottratte ad altri settori fondamentali per il benessere della collettività. Si stima che con il costo di un caccia F-35 si potrebbero realizzare 183 asili nido, compresi gli stipendi per gli insegnanti. Occorre poi riflettere anche in termini di dinamiche di transizione e innovazione: circa l’80% degli investimenti pubblici per l’innovazione tecnologica nell’industria vanno al comparto militare. Ma ciò non ha nessuna giustificazione economica: né dal punto di vista della competitività italiana, né guardando al contributo del comparto al prodotto interno lordo, all’occupazione o alle esportazioni italiane. Non risponde, cioè, all’interesse pubblico ma a quello delle lobby.
Poi c’è l’impatto ambientale…
Idem, devastante e poco considerato. Si stima che il settore militare sia responsabile di circa il 5,5% delle emissioni globali di gas serra: l’aviazione civile, per fare un confronto, si ferma al 2%. Secondo un articolo dell’anno scorso del quotidiano The Guardian, nei primi due mesi della guerra a Gaza le emissioni prodotte dai bombardamenti israeliani sono state pari a quelle annuali di venti dei Paesi più vulnerabili alla crisi climatica. Penso che questi dati bastino per escludere il settore dalla tassonomia europea degli investimenti sostenibili.
Eppure c’è chi sostiene che “se vuoi la pace, prepara la guerra”. Quali strumenti o azioni, invece, sono a disposizione di chi crede che “se vuoi la pace, investi nella pace”?
Intanto bisogna essere selettivi negli investimenti. Una scelta di finanza etica in questo senso è una garanzia, perché esclude categoricamente l’industria militare e il commercio di armamenti: una differenza netta, tra l’altro, con la cosiddetta finanza sostenibile. Ma si può fare di più, come sostenere attivamente chi lavora per la trasformazione non violenta dei conflitti, per aiutare la popolazione civile che ne è vittima. Vuol dire sostenere le organizzazioni non governative internazionali, quelle locali che operano sul posto e anche la società civile che, dal basso, sostiene una leadership alternativa.
Faccio alcuni esempi. In Iraq abbiamo lavorato con tantissime associazioni per i diritti umani che hanno costruito un tessuto democratico dal basso, non attraverso scelte fatte dalle élite. In Palestina e Cisgiordania stiamo sostenendo i comitati popolari che nei villaggi della Cisgiordania, insieme ad attivisti internazionali e a pacifisti israeliani, cercano di resistere all’espansione degli insediamenti illegali e alla violenza dei coloni contro i civili palestinesi. E all’interno del Servizio civile italiano c’è un programma, per ora sperimentale, che prevede Corpi civili di pace, cioè ragazzi del Servizio civile che si recano all’estero, con associazioni come la nostra, per sostenere percorsi per la trasformazione non violenta dei conflitti: come tanti piccoli diplomatici, che crescono. Azioni dal basso come queste, estremamente efficaci perché salvano vite e costruiscono percorsi di coesistenza che superano le linee del fronte, vanno sostenute: questa è l’azione di pace alternativa alla guerra.
Di economia e guerra parleremo a FestiValori, a Modena, venerdì 18 ottobre nel panel “A chi conviene fare la guerra?” con Ugo Biggeri, Chiara Bonaiuti, Sara Caria e Serge Stroobants e la moderazione di Davide Fracasso.



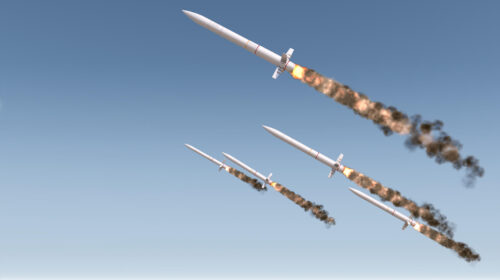
Nessun commento finora.