L’industria militare europea è nelle mani dei soliti noti
Tra gli azionisti delle big dell’industria militare europea ci sono diversi nomi familiari: quelli dei fondi d’investimento statunitensi
L’industria militare europea? È una matrioska. In un momento in cui il tema è purtroppo tornato di stretta attualità a causa della guerra tra Russia e Ucraina, questa metafora suona amara. Ma è comunque la più adatta a descrivere un settore popolato da aziende militari statunitensi ed europee che in teoria dovrebbero farsi concorrenza tra loro ma che, nella pratica, sono connesse l’una con l’altra attraverso un’intricata rete di partecipazioni societarie. E i cui azionisti, oltre agli Stati, sono i grandi fondi d’investimento d’Oltreoceano.
Cinque big degli armamenti si “spartiscono” i fondi europei
Sappiamo che l’Unione europea ha istituito lo European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), dotato di un budget di 500 milioni di euro per il biennio 2019-2020 per «supportare la competitività e la capacità di innovazione dell’industria europea della difesa». Il collettivo di giornalisti Investigate Europe si è posto una semplice domanda: chi incassa questi fondi? Sulla carta, 302 aziende. Non tutte però hanno lo stesso peso. Nonostante l’enfasi posta sulla concorrenza, infatti, i tre quarti della somma vanno a 23 progetti in cui – sotto varie forme – sono coinvolte cinque big: le francesi Dassault Aviation e Thales, la franco-tedesca Airbus, l’italiana Leonardo e la spagnola Indra Sistemas.
Un passo indietro

La guerra in Ucraina lancia una nuova corsa agli armamenti. E ruba risorse
Il “macabro spot” della guerra russa in Ucraina spinge la corsa agli armamenti che sottrae risorse su clima e pandemia. Complice l’opacità delle banche armate
A questo punto diventa interessante capire chi si cela dietro le quinte di questi grandi nomi dell’industria militare europea. La prima risposta? Gli Stati. Il ministero dell’Economia e delle finanze italiano detiene poco più del 30% delle azioni di Leonardo; di poco inferiore (25,6%) la quota di Thales di proprietà del governo francese. Tra gli azionisti di Airbus ci sono il governo francese, quello tedesco (entrambi col 10,9% delle azioni) e quello spagnolo (4,11%). Più limitate le informazioni sull’azionariato di Indra Sistemas, ma spicca il 18,7% detenuto dalla Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, controllata dal ministero del Tesoro iberico.
L’industria militare europea finanziata dai fondi americani
Sempre passando in rassegna l’azionariato, si scoprono altre due cose. La prima: il gioco di specchi per cui, ad esempio, Dassault Aviation detiene poco meno del 25% delle azioni di Thales, ma è a sua volta controllata per il 9,9% da Airbus. E questo è soltanto uno dei tanti casi che, messi insieme, formano un groviglio in cui ogni società è vicinissima a tutte le altre.
La seconda scoperta: tra gli azionisti ci sono nomi che suonano molto familiari. Cioè BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments, Wellington Management e Capital Group, i più grandi fondi d’investimento statunitensi, che comprano indistintamente quote delle aziende belliche del Vecchio Continente e delle loro concorrenti d’Oltreoceano. Per citare il caso più clamoroso, nelle loro mani c’è complessivamente il 13,77% di Airbus e il 13,86% della sua rivale Boeing. Oppure prendiamo BlackRock, il primo fondo a sfondare il tetto dei 10mila miliardi di dollari di asset gestiti. In questi 10mila miliardi ci sono quote di tutte e cinque le big dell’industria militare europea. Ma anche il 4,19% di Northon Grumman, il 4,77% di Raytheon Technologies, il 4,89% di Lockheed Martin, il 3,95% di Boeing e il 3,85% di General Dynamics.

Anche l’industria militare europea è un oligopolio?
La situazione in cui imprese concorrenti hanno alle spalle una compagine azionaria molto simile ha un nome preciso: common ownership. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sottolinea quanto sia sempre più frequente, non solo nell’industria militare europea ma anche nell’aeronautica, nella finanza e nella farmaceutica.
È una logica conseguenza dell’ascesa dei fondi passivi, cioè quelli che non selezionano i titoli ma si limitano a mantenere in portafoglio le azioni e obbligazioni del benchmark di riferimento. Un approccio orientato a diversificare il rischio e non dipendere troppo dalle performance di una specifica azienda. In assenza di politiche di esclusione basate su criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), i fondi passivi finiscono dunque per “pescare” indistintamente tutti i titoli compresi nell’indice. Compresi quelli emessi da produttori di armi, compagnie petrolifere o colossi del tabacco.
In linea di massima, un fondo passivo non dovrebbe avere interesse a intervenire sulle decisioni delle aziende in portafoglio; e la stessa BlackRock, interpellata da Investigate Europe, ha assicurato di non voler incidere in nessun modo sulle strategie dell’industria militare europea.
Resta il fatto che il dibattito sulla common ownership è acceso. Perché, pur essendo una tesi difficile da dimostrare, c’è motivo di credere che questi intrecci proprietari incidano negativamente sulla concorrenza. E sappiamo bene come sono fatti gli oligopoli: poco trasparenti, inclini ad alzare i prezzi e fare lobbying sulla politica. Tutti attributi che, declinati sul settore delle armi, non fanno presagire niente di buono.


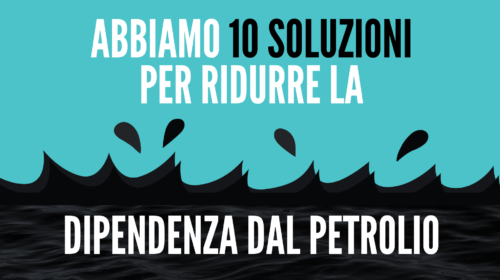
Nessun commento finora.