Moda. L’altra faccia del Made in Italy è lo sfruttamento sistemico nelle filiere
Per concessione della casa editrice, pubblichiamo la prefazione – a cura della Campagna Abiti Puliti – a "La trama del lusso" di Audrey Millet
Per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo la prefazione – a cura della Campagna Abiti Puliti – al saggio di Audrey Millet “La trama del lusso. L’industria della moda tra capitalismo dei corpi e criminalità” (in uscita per Add Editore il 13 febbraio 2026, traduzione di Stefano Renzi). A partire dalla storia di Abdoul, partito dalla Costa d’Avorio per lavorare nella moda ma intrappolato in una catena di sfruttamento che attraversa Africa ed Europa, Millet mostra come il distretto tessile, incluso quello di Prato, sia spesso controllato da reti criminali e caporalato. Attraverso due anni di ricerche, l’autrice denuncia un sistema globale di schiavitù moderna e le sue gravi implicazioni politiche e sociali.
È talmente incredibile il viaggio di Abdoul, lungo, agghiacciante e pericoloso che non sembra possibile che sia sopravvissuto. Il suo destino pare segnato dalla nascita, quando fin da bambino respira l’odore nauseabondo dei rifiuti occidentali che marciscono nella discarica di Akouédo, ottantatré ettari di immondizia che raccontano l’opulenza sfacciata di chi può permettersi di vivere senza pensare alle conseguenze del proprio stile di vita. Tra quegli scarti ci sono anche tessuti, quelli che Abdoul impara presto a cucire per avviarsi a un mestiere anziché studiare, come avrebbe voluto. Diventa bravissimo e mette in forma il suo sogno: diventare indipendente, avere un lavoro che possa restituire dignità a lui e alla sua famiglia, che però non ha i mezzi per procurargli una macchina da cucire.
La sua odissea comincia così, quando decide di mettersi in viaggio per seguire il filo di una strada migliore, passo dopo passo lungo una traiettoria che ben presto diventa un incubo da cui non si torna indietro. La sua vita, la sua storia, il suo sogno, la sua identità sbiadiscono tappa dopo tappa, tradimento dopo tradimento, confine dopo confine, inghiottito nel vortice di uno sfruttamento organizzato alla perfezione, come una catena di fornitura. Alienazione, spossessamento e violenza sono la cifra di un sistema basato sulla collusione tra élite politiche nazionali, reti criminali e imprese, tutte a mandare avanti la macchina che organizza la tratta degli esseri umani. Corpi martoriati, violentati, messi al lavoro finché produttivi e poi gettati via come scarti, a decomporsi tra le dune del deserto del Ténéré, il «Grande Buco» dove tutto si dissolve, lontano dagli occhi delle istituzioni internazionali, paladine di democrazia e diritti ma solo a parole.
Tante le similitudini e le intersezioni tra il viaggio forzato di Abdoul e le catene di fornitura che ogni anno sfornano cento miliardi di capi, cuciti dalle sapienti mani di milioni di lavoratori e lavoratrici come lui. Traiettorie produttive e logistiche che attraversano i continenti, alimentate dalle vite di schiavi moderni che non possono permettersi di indossare le merci che producono, se non quando saranno riversate nei mercati dell’usato nei Paesi di origine, per poi finire in gigantesche discariche illegali a cielo aperto. Novantadue miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno, un camion ogni venti secondi. Scarti tessili che vanno a inquinare irrimediabilmente l’Africa e i Paesi del Sud del mondo, mentre le nuove generazioni vengono attratte in Europa dove, se mai arriveranno vive, finiranno nelle mani dei caporali a fare gli schiavi moderni in fabbriche senza regole, contratti, sindacati, invisibili tra gli invisibili.
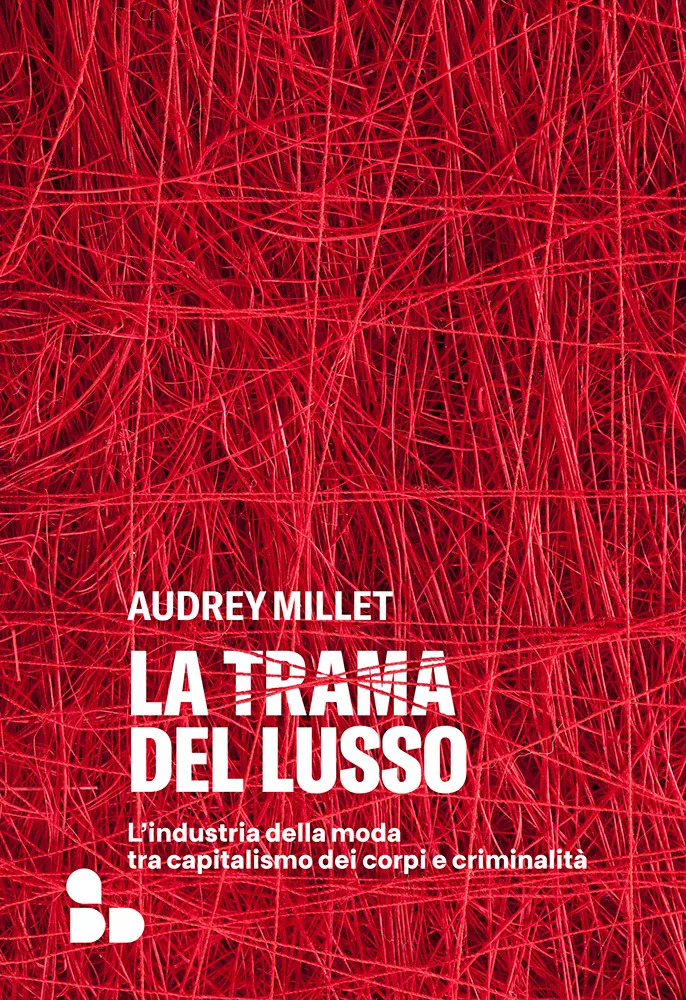
«Catene globali di fornitura» non è dunque una definizione solo tecnica, ma anche politica, è l’onesta e plastica rappresentazione di un sistema di produzione che fonda la sua esistenza sullo sfruttamento continuo e lineare di risorse naturali, umane e non umane per accumulare profitti. Si chiama estrattivismo, il modo capitalista contemporaneo di appropriazione del vivente fondato sul sovrasfruttamento senza limiti. Catene di fornitura che nella moda mettono al lavoro trecento milioni di persone nel mondo, in maggioranza donne, giovani e migranti, costrette a vivere in condizioni miserabili, sotto ricatto, senza documenti e diritti di cittadinanza, destinate a lavorare in fabbriche insalubri e insicure. E nelle fabbriche, dove i ruoli apicali sono occupati da uomini, i capilinea usano ogni mezzo, dagli insulti alle pressioni psicologiche agli schiaffi, per disciplinare le giovani operaie costrette a lavorare anche tra le dieci e le dodici ore al giorno, a causa di ritmi di lavoro intensi e picchi produttivi. Senza dimenticare la violenza economica, che aumenta il rischio di abusi e violazioni quando le lavoratrici si vedono costrette ad accettare orari estenuanti per provare ad arrivare a fine mese e mantenere le famiglie, spesso distanti e dipendenti dalle loro rimesse.
Prendiamo il caso del Bangladesh, secondo produttore di fast fashion dopo la Cina, dove anche i marchi del lusso fanno produrre le seconde linee e sono impiegate quattro milioni di lavoratrici; anche nelle fabbriche verdi più avanzate e pluri-certificate, le operaie guadagnano salari insufficienti a uscire dalla spirale della povertà, non sono sindacalizzate e subiscono soprusi e violenze quotidiane. È il loro sacrificio che ha permesso la crescita esponenziale degli indicatori macroeconomici del Paese, sponsorizzati come un vantaggio per lo sviluppo, ma possibili solo grazie a un regime di sfruttamento di genere e razzializzato: le lavoratrici dell’industria tessile del Bangladesh sono preziose per l’economia globale proprio perché sono economiche, docili e sacrificabili.
Se ci spostiamo in Italia – la patria del Made in Italy, dell’eccellenza artigiana e del lusso –, troviamo sorprendenti analogie, sempre confinate a fatti di cronaca, le classiche mele marce che non devono macchiare l’immaginario estetico ed etico del settore. Proprio a Milano, cuore pulsante delle passerelle delle maison del lusso, sono nate le indagini della procura che hanno fatto il giro del mondo. Numerosi i marchi accusati di agevolazione colposa del caporalato e pesante sfruttamento, in seguito alle ispezioni effettuate dai carabinieri del Nucleo tutela del lavoro presso i loro terzisti, situati nell’hinterland milanese, dove gli operai-schiavi mangiano, dormono e lavorano per pochi euro all’ora, soprattutto di notte e nei festivi, in capannoni fatiscenti e insicuri a conduzione cinese.
Le indagini della procura, che ha chiesto l’amministrazione giudiziaria per i marchi coinvolti, hanno destato allarme e nervosismo perché parlano di un sistema rodato e diffuso in cui convivono mondi solo apparentemente distanti: quello delle grandi griffe, che vendono prodotti di lusso a migliaia di euro, e quello dei loro fornitori operanti nell’illegalità, che li producono a prezzi stracciati pagando salari di fame. Mondi che si accordano e colludono verso un unico obiettivo: abbattere i costi e massimizzare i profitti, violando leggi e contratti istituiti per contenere lo strapotere del mercato e, di fatto, inibire il ricorso alle forme più oscene di sfruttamento.
Bastano poche ore di treno da Milano per arrivare nel distretto tessile più importante d’Europa, cuore della commistione tra pronto moda, contraffazione e lusso vero, commissionato dalle griffe alla ricerca del Made in Italy a basso costo. Lo racconta bene Abdoul, al termine della lunga odissea che lo conduce proprio a Prato, lui, sarto sopravvissuto all’inferno della migrazione e subito inghiottito nelle viscere del Macrolotto. Se non fosse stato per l’incontro fortuito con Audrey Millet sulle strisce pedonali della città toscana, la sua storia sarebbe rimasta nascosta dietro le mura di un anonimo capannone. Millet non è solo una storica e ricercatrice, ma anche un’attivista vicina alla Clean Clothes Campaign, il network internazionale di oltre duecentoventi organizzazioni che da più di vent’anni si batte in tutto il mondo per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore tessile, e di cui Campagna Abiti Puliti è la sezione italiana.
L’altra faccia del Made in Italy – quella che si vuole nascondere per continuare a promuovere una retorica della sostenibilità che, come ormai è sotto gli occhi di tutti, fa acqua da tutte le parti – Millet la lascia raccontare a lui. Prato è lo snodo fondamentale di un settore produttivo ancora molto rilevante che nel 2019 contava 56.000 imprese e circa 465.000 addetti, oggi al centro di una crisi strutturale che macina milioni di ore di cassa integrazione e manda in default migliaia di aziende. Il celebrato modello dei distretti pare ormai archeologia industriale archiviata nei libri di storia economica, mentre i territori mostrano tutta la vulnerabilità di un sistema produttivo esausto, spolpato fino al midollo da catene del valore asimmetriche che da decenni drenano ricchezza verso l’alto, a beneficio degli azionisti e dei manager dei grandi gruppi. Il prezzo più alto lo pagano naturalmente le lavoratrici e i lavoratori, ultimo anello di una catena che li intrappola dentro un destino sociale già scritto.
Se l’Europa e gli Stati agissero in conformità al diritto internazionale e alle Costituzioni, dovrebbero adottare e applicare leggi che obbligano tutte le imprese a rispettare i diritti umani e l’ambiente, ovunque esse operino. Invece il mondo gira al contrario e le istituzioni che dovrebbero proteggere cittadini e lavoratori dalle conseguenze negative delle attività economiche, riequilibrando i rapporti di forza che il mercato non può sanare, agiscono a tutela delle imprese e di uno sviluppo finalizzato al profitto di pochi.
Mentre viene automaticamente rinnovato il memorandum tra Italia e Libia garantendo un futuro florido ai lager per migranti e alla guardia costiera libica per bloccare le partenze verso le coste italiane, l’Unione europea, tramite il pacchetto Omnibus, si accinge a smantellare importanti riforme sulla sostenibilità nel tessile previste dal Green Deal, svuotando di efficacia importanti direttive approvate dalla stessa Unione meno di due anni fa, come quella sul dovere di diligenza che introduce per le imprese di certe dimensioni l’obbligo di adottare pratiche di vigilanza in materia di diritti umani, tutela ambientale e diritti del lavoro lungo la filiera. In Italia le cose vanno ancora peggio.
La politica non riconosce e nemmeno premia lo straordinario lavoro della procura di Milano che, grazie alle sue accurate indagini, indica gli ambiti di intervento che potrebbero prevenire l’intervento giudiziario. Il governo italiano non solo si è distinto per posizioni di retroguardia a livello europeo, ma svolge un ruolo attivo nella promozione di norme nazionali pro-mercato che hanno il solo scopo di proteggere i brand ed esonerarli dalle loro responsabilità verso i fornitori.
La Campagna Abiti Puliti, oltre a denunciare gli impatti sociali della moda, porta all’attenzione delle imprese e del legislatore proposte concrete per una riforma del settore verso una transizione giusta che deve porre al centro il protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici.
Di fronte all’ignavia della politica, è oggi più che mai cruciale rinsaldare le reti di solidarietà internazionale che operano a tutela del lavoro e premono dal basso perché chi detiene il potere di cambiare le cose lo eserciti, a protezione dei diritti umani e dell’ambiente. Ciò non avverrà senza traumi, perciò è vitale favorire ampi processi di convergenza tra chi lotta per la giustizia sociale e chi lotta per la giustizia ecologica per almeno due motivi: il primo è che non potrà esservi alcuna trasformazione dei modi di produzione senza il protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici, che subiscono gli impatti più devastanti della crisi ambientale causata dal modello capitalista estrattivo. Il secondo è che tutto è interconnesso: le catene poste sulla vita dei milioni di Abdoul che provano a varcare i confini e osare la speranza, sono le stesse che estraggono valore dalla natura e dalle persone per produrre merci a basso costo e montagne di rifiuti che concorrono alla policrisi planetaria.
Sono queste catene che dobbiamo spezzare, insieme ad Abdoul e a tutti i lavoratori e le lavoratrici che indicano la strada per una transizione che non lasci indietro nessuno. Come recita lo slogan della campagna di solidarietà internazionale promossa dal combattivo sindacato Sudd Cobas e dalla Clean Clothes Campaign (CCC) a sostegno dei lavoratori della filiera Montblanc: non per noi, ma per tuttə.


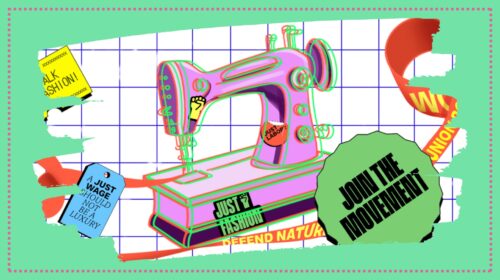

Nessun commento finora.