Cop sul clima: cosa hanno ottenuto (e dove hanno fallito)
Cosa hanno ottenuto davvero le COP sul clima? Dai primi accordi fino a oggi, tra traguardi raggiunti e obiettivi mancati
Il 1992 è stato un anno eccezionale. Un anno in cui l’intera comunità internazionale si è unita per provare a dare un nuovo indirizzo al proprio sviluppo, al proprio modo di stare al mondo. E non in senso figurato. Lo storico Summit della Terra di Rio de Janeiro ha dato vita a tre trattati che hanno riconosciuto l’urgenza di salvaguardare le risorse, limitate, dell’unico pianeta a nostra disposizione.
Tra questi c’era anche la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc). Che a sua volta ha dato vita a una serie di incontri tra le parti – ovvero gli Stati che hanno aderito all’Unfccc – volti a trovare gli strumenti e i modi per limitare le emissioni di gas a effetto serra causate da carbone, petrolio e gas. E nel farlo hanno provato a rispettare il cosiddetto “principio di responsabilità comune, ma differenziata”. Ovvero quel principio secondo il quale i Paesi industrializzati sono chiamati a fare la parte del leone nella mitigazione, ovvero nella riduzione delle emissioni. Un concetto che ha dato vita a un quadro politico a dir poco complesso e ambizioso, ma ancora poco concreto, efficace. Questa è la storia dei principali risultati raggiunti.

1997, Cop3 di Kyoto: il primo accordo vincolante, troppo debole per il clima
La prima Cop si svolge a Berlino – in Germania – nel 1995, l’anno dopo l’entrata in vigore dell’Unfccc. E nel 1997, alla Cop3 di Kyoto, in Giappone, viene adottato il primo vero impegno vincolante per i Paesi industrializzati, chiamati a ridurre le emissioni di gas serra del 5 per cento entro il periodo 2008-2012, rispetto ai livelli registrati nel 1990. È il Protocollo di Kyoto, un documento innovativo che introdusse meccanismi di mercato delle emissioni e il Clean development mechanism per favorire riduzioni di gas serra a costi – teoricamente – contenuti.
Ma la sua efficacia fu limitata. Gli Stati Uniti, pur avendolo inizialmente firmato, non lo ratificarono mai a causa di un cambio politico alla Casa Bianca (erano gli anni dell’amministrazione guidata da George W. Bush). Washington, infatti, già allora ritenne inaccettabile che i grandi Paesi emergenti – quali Cina e India – non avessero obblighi di riduzione della CO2 vincolanti. La sfida di un’azione per il clima condivisa restava tutta da risolvere.
A causa di questo cambio di rotta degli Stati Uniti, l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenne 7 anni dopo, nel 2005. Un tempo troppo lungo durante il quale le emissioni non hanno fatto altro che aumentare. E per questo, era già venuto il momento di pensare a nuovo accordo, più ambizioso, che coinvolgesse davvero anche i Paesi allora definiti emergenti.
2015, Cop21 di Parigi: un accordo storico, ma senza vincoli reali
Il nuovo accordo, inizialmente, doveva essere raggiunto alla Cop15 di Copenaghen. Correva l’anno 2009, ma nei fatti questa conferenza si trasformò nel più grande fallimento del processo negoziale. Ciò perché la comunità internazionale si rese conto di essere molto più divisa di quanto pensasse. E tutto venne rinviato, anzi annullato. Il percorso dovette ricominciare da zero e per questo ci vollero altri sei anni per raggiungere un accordo inclusivo e sostenibile.
La linea temporale ci porta quindi a Parigi, in Francia, per la Cop21 del 2015. Questa conferenza segnò davvero un cambio di paradigma. Per la prima volta, quasi tutti i Paesi del Nord e del Sud del mondo assunsero impegni volontari di riduzione delle emissioni. Si tratta delle Nationally determined contributions, da aggiornare ogni cinque anni. L’obiettivo dichiarato fu limitare il riscaldamento «ben al di sotto dei 2 gradi centigradi». Con l’aspirazione – fortemente sostenuta dalla comunità scientifica – di rimanere attorno agli 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale.
Ma Parigi nacque debole: gli obiettivi, infatti, non erano vincolanti, bensì promesse di azione che hanno finora dimostrato di essere largamente insufficienti e fuori rotta. Il sistema quinquennale di revisione e trasparenza – il global stocktake – avrebbe dovuto spingere verso un maggiore controllo e ambizione. Ma la realtà racconta un’altra storia.
Il limite di 1,5 gradi è fuori portata: cosa dice oggi la scienza
Uno degli studi più recenti pubblicato su Earth System Science Data da 61 scienziati internazionali – molti dei quali fanno parte dell’Ipcc, ovvero il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici che periodicamente aggiorna i governi sullo stato in cui versiamo – ha certificato quanto in molti immaginavano, ma non avevano il coraggio di ammettere: il limite di 1,5 gradi è ormai impossibile da raggiungere. Il carbon budget residuo, cioè la quantità di CO2 che possiamo ancora emettere per restare entro quella soglia di aumento della temperatura media globale, si esaurirà in meno di tre anni al ritmo attuale di emissioni. Un ritmo accelerato dall’aumento di metano in atmosfera, un gas serra più limitato, ma più potente per la capacità di trattenere il calore in atmosfera.
Questo significa che, senza una svolta immediata, il Pianeta supererà stabilmente gli 1,5 gradi già entro il 2030. Con conseguenze catastrofiche – come previsto dal rapporto speciale che l’Ipcc ha pubblicato nel 2018 – in termini di eventi estremi, crisi idriche e perdita di biodiversità. Anche il limite di 2 gradi centigradi è a rischio. Il budget consentito per non superare questa soglia, sempre al ritmo attuale, sarà esaurito entro 25 anni se non si agisce ora in modo rapido.
2022, Cop27 di Sharm el-Sheikh: nasce il fondo per perdite e danni climatici
E veniamo al 2022, alla Cop27 egiziana. Che ha segnato un piccolo passo in avanti nell’applicazione del principio di responsabilità comune, ma differenziata, grazie alla creazione del fondo loss and damage. Si tratta del fondo per riparare alle perdite e ai danni subiti dai Paesi più vulnerabili alla crisi climatica. Che, fino a poco tempo fa, erano anche quelli meno responsabili della crisi stessa.
Questo fondo rappresenta un riconoscimento formale che, oltre alla mitigazione e all’adattamento, sia indispensabile un sostegno finanziario e tecnologico concreto alle comunità colpite da inondazioni, siccità e disastri sempre più potenti e frequenti. Tuttavia, la raccolta e l’effettiva erogazione dei fondi restano un interrogativo enorme.
2023, Cop28 di Dubai: per la prima volta si parla di combustibili fossili
La Cop28, svoltasi negli Emirati Arabi Uniti – terra di petrolio –, ha rappresentato un unicum. Per la prima volta in un testo negoziale ufficiale è stata menzionata esplicitamente la necessità di un progressivo abbandono dei combustibili fossili (transitioning away from fossil fuels). Ovvero si scriva nero su bianco che c’è bisogno di attuare una transizione dai combustibili fossili al fine di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050, in linea con quanto affermato dalla scienza. Sebbene la dichiarazione resti ambigua perché non definisce in modo chiaro modi e tempi e il linguaggio appaia ancora come un compromesso frutto delle pressioni dei Paesi produttori di petrolio e gas, questa citazione rompe un tabù durato decenni: l’utilizzo dei combustibili fossili – causa principale della crisi climatica – sono ora parte ufficiale della discussione.
Questo riconoscimento, seppur parziale, è uno spiraglio importante. Ma le azioni rimangono insufficienti e la dipendenza globale da carbone, petrolio e gas non accenna a diminuire, nonostante un’esplosione tecnologica delle rinnovabili con un conseguente abbassamento dei costi. Il rischio è che la transizione venga rinviata troppo a lungo, con conseguenze sempre più drammatiche. Perché una cosa va ricordata: per ridurre le emissioni non basta ridurre la percentuale del mix energetico ad appannaggio dei combustibili fossili, serve ridurre drasticamente la produzione assoluta fino a portarla a zero.
L’inerzia della politica e l’urgenza di agire: ogni decimo di grado conta
L’inerzia della politica e il sonno della società civile ha ormai reso quasi impossibile centrare il limite degli 1,5 gradi, ma l’azione resta urgente e indispensabile per contenere i danni peggiori.
Ogni decimo di grado di aumento evitato conta, ogni soluzione è fondamentale. Ogni giorno investito per la transizione è un guadagnato. Per questo Belém e le prossime conferenze delle parti sono fondamentali per il nostro futuro. Siamo artefici del nostro destino. Siamo causa del problema, ma siamo anche soluzione. E questo è sia un dramma che una speranza.

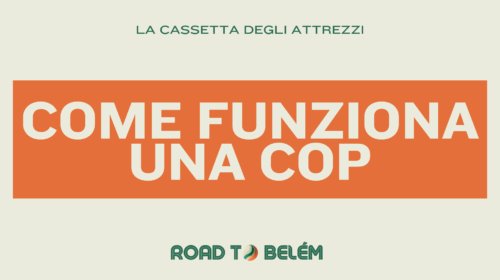

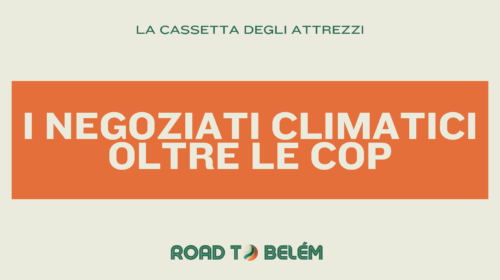
Nessun commento finora.