Unfccc: cos’è, perché è nata e perché oggi serve una rifondazione
Dal summit di Rio alla Cop30 di Belém: storia, obiettivi e limiti della Convenzione Onu sul clima. E perché oggi serve una rifondazione
Nel 1992, a Rio de Janeiro, la comunità internazionale si riunì – sotto l’egida delle Nazioni Unite – nel folle tentativo di fare ordine in un disordine ecologico e geopolitico che minacciava gli equilibri globali. Il muro di Berlino era caduto da poco mettendo fine a decenni di Guerra fredda. Si faceva largo l’idea di un nuovo sistema nel quale per la prima volta ambiente, economia e diritti umani venivano riconosciuti come questioni globali, ma soprattutto interconnesse. Fu in quel contesto che nacquero tre grandi convenzioni internazionali. Quella sulla biodiversità (Convention on Biological Diversity – Cbd), quella contro la desertificazione (United Nations Convention to Combat Desertification – Unccd) e l’Unfccc, ovvero la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change), che da allora guida i negoziati internazionali sul clima.

L’Unfccc: come funziona la Convenzione Onu sul clima
L’Unfccc è un trattato internazionale firmato entrato in vigore nel 1994 e ratificato, oggi, da 198 paesi. Non è un accordo vincolante nel senso classico. Si tratta di un quadro normativo all’interno del quale sono stati stabiliti i principi fondamentali per affrontare quella che poi sarebbe stata ribattezzata “crisi climatica”. Ma che all’epoca era meglio nota come riscaldamento globale. Ovvero quel fenomeno causato dallo sfruttamento senza controllo dei combustibili fossili, quali carbone, petrolio e gas. Il suo obiettivo primario è «stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera a un livello che prevenga interferenze pericolose con il sistema climatico». Una definizione volutamente ampia e preventiva, fondata su pilastri giuridici come la precauzione, la prevenzione, l’equità e lo sviluppo sostenibile.
La convenzione sul clima, quindi, non nasce per imporre sanzioni, bensì per coordinare l’azione internazionale. Il suo scopo è propositivo, non punitivo. È costruttivo, non repressivo. Per questo l’Unfccc dapprima promuove il dialogo attraverso lo svolgimento di conferenze annuali, chiamate Cop, tra tutte le parti aderenti (i negoziati sul clima), poi facilita gli impegni nazionali creando un terreno fertile per strumenti giuridici più stringenti. Come sarebbe stato poi il Protocollo di Kyoto adottato alla terza conferenza delle parti del 1997 o l’Accordo di Parigi del 2015. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla volontà politica degli stati che hanno aderito e dal rispetto reciproco degli accordi.
Anche il finanziamento dei vari piani d’azione è un aspetto chiave. Quelli che una volta venivano chiamati “Paesi industrializzati”, oggi noti come “Paesi del Nord del mondo”, erano chiamati a contribuire secondo i principi di responsabilità storica e capacità economica. Un tema ancora oggi al centro delle tensioni diplomatiche. In poche parole, chi ha contribuito di più al riscaldamento globale, deve agire per primo e più in fretta. Per questo accanto ai finanziamenti diretti dei governi, negli anni sono nati fondi multilaterali, come il Fondo verde per il clima (Green Climate Fund). E si è sviluppato un complesso ecosistema di partenariati pubblico-privati che avevano come obiettivo quello di trasferire risorse e competenze dai Paesi del Nord a quelli del Sud, meno responsabili delle emissioni di gas serra (come l’anidride carbonica, CO2) e meno tecnologicamente pronti a far fronte, ad adattarsi a un clima più caldo. Quindi più “estremo”.
Perché la comunità internazionale ha agito troppo tardi
La crisi climatica non è una scoperta del 1992. La scienza aveva lanciato l’allarme già negli anni Settanta del Novecento, con la prima World climate conference del 1979. Tuttavia, l’azione politica ha accumulato decenni di ritardo, dovuti a molteplici ragioni strutturali. Tra queste, il peso della lobby fossile guidata da multinazionali pronte a tutto pur di salvaguardare il profitto. Ma anche la storica asimmetria di potere tra Nord e Sud del mondo, l’ossessione per la crescita economica a ogni costo. E – come anticipato – l’assenza di meccanismi giuridici vincolanti a livello globale che potessero dirimere controversie tra stati sovrani.
Ma soprattutto, la crisi climatica è la quintessenza della crisi di un modello di sviluppo economico, quello capitalistico, impregnato violenza, sfruttamento e diseguaglianza che affonda le sue radici nel colonialismo. Non una semplice emergenza ambientale, quindi, anche se spesso si è cercato di confinarla come una mera questione tecnica, a esclusivo appannaggio di esperti e funzionari. E solo recentemente affrontata come un problema anche politico, etico e di giustizia sociale. Per questo oggi si parla apertamente e più convintamente di giustizia climatica.
Le tre convenzioni adottate alla conferenza di Rio: biodiversità, desertificazione e clima
Alla Conferenza di Rio nacquero non una, ma tre convenzioni fondamentali: oltre all’Unfccc, la Convenzione sulla diversità biologica e la Convenzione per combattere la desertificazione. Questi tre strumenti, pur distinti, affrontano sfide ambientali profondamente interconnesse: la perdita di biodiversità accelerata dal riscaldamento globale, ma che a sua volta è spinta propulsiva alla crisi climatica. E poi c’è il fenomeno della desertificazione che amplifica le vulnerabilità ambientali e i disagi sociali di intere regioni e popolazioni. Tuttavia, nella pratica, queste convenzioni continuano a operare in modo separato, a compartimenti quasi stagni. Hanno sedi in località differenti (Bonn e Montréal), cicli negoziali (annuali e biennali) e strutture burocratiche autonome pur riferendosi tutte all’Onu, la cui sede è a New York. L’assenza di un coordinamento efficace, dunque, limita la capacità del sistema multilaterale di affrontare in modo integrato le sfide ambientali e sociali del pianeta.
Dalla Cop29 di Baku alla Cop30 di Belém: la sfida della riforma
La recente Cop29 di Baku, in Azerbaigian, ha rappresentato un passaggio tecnico cruciale per ridefinire l’obiettivo finanziario globale per il clima. Mentre la prossima Cop30 di Belém, di nuovo in Brasile (che sia di buon auspicio?) si presenta come un banco di prova politico per capire se la comunità internazionale è pronta per salvarsi e salvare ciò che le ha consentito di svilupparsi a ritmi forsennati. Del resto, gli eventi estremi ormai sono sempre più frequenti e trasversali. Se prima colpivano soprattutto i Paesi più vulnerabili e meno responsabili del riscaldamento globale, oggi stanno moltiplicando la loro potenza e frequenza. Mettendo così in ginocchio persino i governi e le popolazioni finora considerate erroneamente meno soggette ad alluvioni, ondate di calore o altri eventi estremi. Dal Nordamerica all’Europa, dalla Cina all’Australia. Ogni regione ha vissuto la potenza e la follia della crisi climatica.
Per questo sono innumerevoli le organizzazioni internazionali – di ogni tipo e dimensione – che chiedono una riforma profonda del processo multilaterale. “Il negoziato” oggi rischia di apparire autoreferenziale, distante dai diritti dei popoli più colpiti e dalle esigenze dei paesi più vulnerabili. Le critiche principali riguardano l’opacità e la lentezza delle decisioni, i veti incrociati di Paesi che guardano solo alla propria economia, i conflitti di interesse causati dalla partecipazione attiva di molti governi in molte compagnie petrolifere che – dal loro canto – continuano a fare pressione in sede internazionale per dilazionare le decisioni e continuare a chiudere contratti miliardari (qualunque sia la valuta che si prende in considerazione). Il sistema annuale delle conferenze delle parti appare sempre più farraginoso, sconclusionato e disconnesso dalle realtà che dovrebbe proteggere.
L’appello congiunto di numerose reti e movimenti chiede quindi una revisione delle regole, come l’introduzione del voto a maggioranza al posto del consensus, più trasparenza finanziaria, l’accesso garantito a delegati e osservatori di ogni parte del mondo e la garanzia che i Paesi che ospitano il processo si impegnino alla tutela dei diritti umani fondamentali. Senza dimenticare il rafforzamento dei legami e dell’integrazione tra obiettivi e risultati delle tre convenzioni di Rio, oltre che l’allineamento con gli altri trattati internazionali che non per forza rientrano sotto il cappello delle Nazioni Unite.
Verso un nuovo patto tra finanza, clima e giustizia
A più di trent’anni dalla sua fondazione, l’Unfccc deve scegliere come (re)stare al mondo, che ruolo assumere. In un mondo sempre più veloce, minacciato da crisi geopolitiche e conflitti, dominato dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale, è ancora possibile che la specie umana si metta d’accordo o c’è bisogno di qualcosa di sovraumano? La crisi climatica non aspetta e il rischio è di vedere minacciata la nostra stessa esistenza. Siamo pronti ad allocare tempo e denaro per garantirci un futuro equo, giusto e sostenibile?

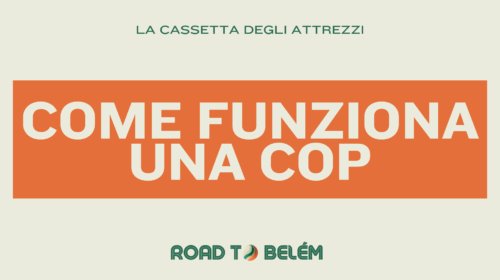

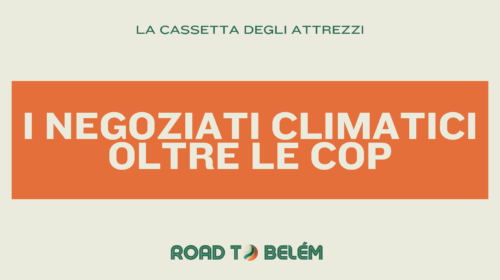
Nessun commento finora.