Concentrazioni e oligopoli. Se un pugno di colossi controlla l’economia mondiale
In tutti i settori fusioni e acquisizioni si moltiplicano, spesso con pesanti costi sociali. Ecco cosa comporta la diffusione degli oligopoli
Il valore complessivo delle fusioni e acquisizioni concluse nel mondo tra gennaio e aprile del 2021 è pari a 1.770 miliardi di dollari. Un record storico, secondo i dati della società anglo-americana Refinitiv. Il dato risulta in crescita del 124% rispetto all’anno precedente. Per le grandi aziende, in particolare, la soluzione alla crisi passa dunque per l’aumento delle dimensioni. Più grandi, più forti. Una frenesia trainata in particolare dagli Stati Uniti, nei quali si concentra un valore superiore ai mille miliardi di dollari. Ma per i consumatori, per l’economia, per i mercati e per quelle stesse aziende, si tratta di strategie virtuose? E qual è il costo sociale della diffusione sempre più ampia degli oligopoli?
«Chi fa ricerca – spiega Audrey Rouziès, docente presso la Scuola di Management di Tolosa ed esperta di fusioni e acquisizioni – sa che non più del 50% delle operazioni riesce. Ma si può arrivare anche 70% se si prendono in considerano alcune variabili. Se ci si chiede, dunque, se si tratti di scelte redditizie, occorre capire rispetto a cosa. Per la Borsa e gli azionisti certamente gli effetti sono importanti. È noto infatti che i titoli crescono rapidamente dopo l’annuncio. Ma se guardiamo queste operazioni da un punto di vista complessivo, tenendo cioè conto anche di performance non finanziarie, non funzionano sempre. Anzi, spesso vanno a finire male. E, in questi casi, i manager faticano a centrare gli obiettivi definiti all’inizio».
«Non più del 50% delle fusioni e acquisizioni risulta un successo. Anche meno, se si considerano determinati parametri»
Nonostante i costi sociali, la tendenza è verso gli oligopoli in tutti i settori
Per non parlare dei costi sociali che presentano numerose fusioni e acquisizioni. Per accontentare gli azionisti i programmi spesso prevedono drastici piani di prepensionamenti e licenziamenti. Il primo obiettivo consiste infatti, quasi sempre, nel rispondere a logiche di breve termine, di bilancio e di ritorno sugli investimenti. I posti di lavoro rappresentano una leva, in questo senso.
Ciò nonostante, la tendenza è chiara: dal commercio alimentare ai mezzi d’informazione, passando per l’acqua, l’energia, il web e i servizi bancari, la maggior parte dei settori è dominato ormai da un pugno di grandi multinazionali. La diversità di marchi che abbiamo di fronte, spesso nasconde la realtà. Quella di una serie di “oligopoli di fatto”. Che sviliscono la concorrenza e portano spesso a posizioni (ufficialmente o meno) dominanti.
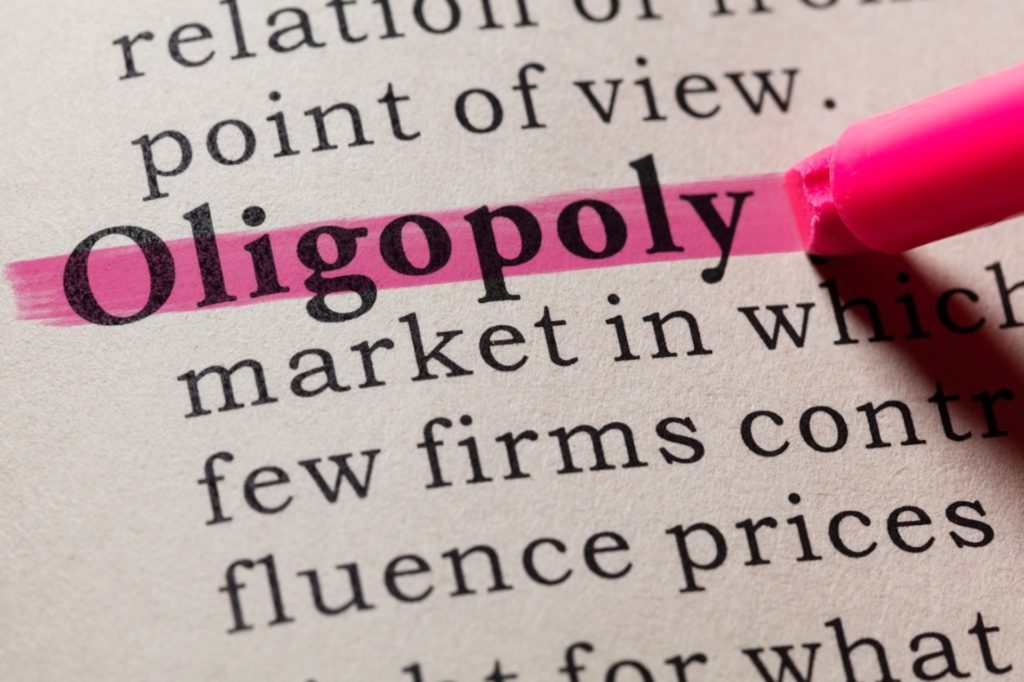
«Acquisizioni e fusioni – osserva Alberto Zoratti, presidente di Fairwatch – aumentano il potere di mercato dell’impresa. Consentendole così di avere un maggior controllo nella filiera, sia integrando certe attività, sia controllando le fasi logistiche e produttive più strategiche. Questo permette di imporre in modo più cogente le strategie dell’azienda. Che possono, anche se non è automatico, sfociare in deroghe sugli standard ambientali e sociali. Vero è che un maggior controllo centralizzato depotenzia gli altri stakeholder nella filiera. Basterebbe pensare che le fusioni portano a oligopoli, che di fatto aumentano il potere contrattuale delle imprese verso produttori, fornitori e aziende terziste».
«I poteri pubblici sono diventati accondiscendenti sulle concentrazioni»
Una situazione che è stata avallata e agevolata anche da numerosi attori della politica. A livello nazionale ma anche sovranazionale. «I poteri pubblici che lottavano un tempo contro i monopoli sono divenuti accondiscendenti sulle concentrazioni – osserva l’economista Philippe Crevel -. Lo fanno pur di creare soggetti forti nazionali e internazionali. I dirigenti d’impresa hanno venduto l’idea che l’economia di scala sia la chiave della competitività. In realtà, questo processo ha avvantaggiato soprattutto gli azionisti. Nel frattempo, le posizioni dominanti si sono moltiplicate con la crescita del settore delle nuove tecnologie. E i colossi possono frenare l’accesso al mercato dei concorrenti decidendo di acquistarli».
«Considerato che le fusioni – aggiunge Zoratti – servono per aumentare la competitività sui mercati globali, e che questa molte volte si basa sul taglio dei costi in produzione, è molto probabile che gli standard sociali e ambientali ne possano risentire. Il contraltare è che sta aumentando la sensibilità etica dei consumatori, anche nei Paesi emergenti. Anche se spesso questa viene soddisfatta con politiche più legate a un marketing aggressivo sui temi della sostenibilità che non a un cambio strutturale delle modalità di produzione. Marketing e posizionamento di mercato che sono tanto più forti quanto più i competitor sono pochi».
«È stata venduta l’idea che l’economia di scala sia la chiave della competitività»
Secondo loro, favorire l’emergere di società dotate della “massa critica” sufficiente per pesare nella globalizzazione, generando spesso oligopoli, è stato negli ultimi decenni il leitmotiv che ha giustificato innumerevoli operazioni di fusione e acquisizione. Per questo General Electric ha comprato Alstom. Per la stessa ragione Fiat si è unita a Chrysler, e poi a PSA (del quale già facevano parte Peugeot, Citroen e Opel) per creare il maxi-gruppo Stellantis. E Nokia ha acquisito Alcatel.
E ancora AOL – Time Warner e Verizon Communications – Cellco nel 2000. I colossi della birra AB Inbev e SABMiller nel 2004. I giganti delle telecomunicazioni AT&T e Time Warner nel 2016. RFS Holdings e ABN Amro nel settore bancario (2007). Royal Dutch Petroleum e Shell Transport & Trading (2005) e Exxon e Mobil (1998) nel settore petrolifero. Pfizer e Warner-Lambert nella farmaceutica (1999). Air France e KLM nel comparto aereo (2004). Bayer e Monsanto, ChemChina e Syngenta e Dow e DuPont nella chimica. Lafarge e Holcim nei cementifici. Essilor e Luxottica nell’occhialeria. E l’elenco potrebbe continuare a lungo.
«Il problema – aggiunge Rouziès – è che per i grandi gruppi a lavorare sulle pre-acquisizioni sono pochissime persone. Parliamo della fase di due diligente, nella quale si discutono gli obiettivi strategici, le sinergie. A gestirle sono i top management delle aziende, alcuni avvocati e banchieri d’affari e qualche consulente. Una decina di persone, a fronte magari di 50mila dipendenti. Molte delle quali hanno un unico faro: concludere l’affare prima possibile. Perché appena si firma, possono fatturare. Invece occorrerebbe andare con calma. Riflettere. Capire cosa si sta comprando o con chi ci si sta fondendo. Altrimenti, più tardi i nodi arriveranno al pettine».
Le due diligence di fusioni e acquisizioni spesso affidate a un pugno di persone
In Europa in molti hanno agevolato tali processi, con l’obiettivo di riuscire ad entrare in concorrenza con i colossi cinesi e americani. Gli oligopoli settoriali che ne sono discesi hanno reso tali aziende, però, estremamente potenti. Anche in termini di lobbying: il caso del Dieselgate nel comparto automobilistico l’ha messo in luce. Esattamente come i negoziati per il finanziamento della ricerca sul vaccino anti-Covid e sulla vendita delle dosi da parte di Big Pharma. O come nel caso del braccio di ferro con i colossi del web Amazon, Google, Facebook e Apple.
Così, nel mondo l’economia è rappresentata da un numero sempre più ristretto di grandi nomi. Un esempio per tutti: l’agricoltura. Ormai, quattro multinazionali controllano i tre quarti del mercato mondiale dei pesticidi e dei semi. Eppure esistono, o dovrebbero esistere, delle regole antitrust. All’inizio del Ventesimo secolo la prima grande vittoria contro il potere eccessivo delle super-concentrazioni fu ottenuta contro la Standard Oil di John D. Rockefeller. Il colosso fu smantellato in 34 società distinte.
Oggi la dinamica sembra uguale e contraria. Il settore della finanza è un esempio evidente. A partire dalla crisi finanziaria del 2008, gli investimenti hanno voltato le spalle ai fondi tradizionali e si sono gettati sugli exchange-trade funds (ETF). Si tratta di strumenti che puntano a riprodurre il più possibile il rendimento di un indice borsistico. Il vantaggio è il fatto che l’indice è composto da numerosi titoli, il che dovrebbe renderli meno rischiosi.
Gli oligopoli nella finanza e l’esplosione delle SPAC
Ebbene, questo settore è letteralmente dominato da tre attori americani: BlackRock, Vanguard e State Street. Le “Big Three” si spartiscono più del 90% del denaro investito nel settore. E rappresentano i principali azionisti dell’88% delle imprese quotate nell’indice S&P500. Uno strapotere che si esprime anche nella governance delle imprese: le tre imprese votano infatti nel 90% dei casi a favore delle risoluzioni proposte dal management. Con un’eccezione: la rielezione dei membri dei consigli d’amministrazione. In questo caso, non necessariamente BlackRock, Vanguard e State Street si allineano. I board, in altre parole, sono di solito sostenuti dai tre colossi, ma a condizione che siano composti da persone che siano di loro gradimento.

L’impennata delle fusioni e acquisizioni fa inoltre leva sulle cosiddette SPAC. La sigla sta per special purpose acquisition company, ovvero società create appositamente in vista di un’acquisizione. In termini concreti, una SPAC è una struttura quotata in Borsa con l’obiettivo di effettuare l’operazione. Al momento della quotazione, è una scatola vuota e, contrariamente ad un ingresso classico in Borsa, i fondi raccolti non sono attribuiti ad un progetto preciso. Sono al contrario conservati sotto forma di liquidità per completare, appunto, l’acquisizione.
Ebbene, il valore delle acquisizioni effettuate attraverso le SPAC nel 2021 è di circa 287 miliardi di dollari a livello mondiale. Nello stesso periodo dell’anno precedente era stato di soli 7,6 miliardi. Al contempo, non manca la spinta dei fondi di private equity, che hanno segnato da parte loro un record storico, con affari siglati per 312 miliardi.
Nessun commento finora.