Accordo di Parigi: così abbiamo perso dieci anni, anche per colpa di colossi italiani
Un rapporto fa i nomi degli attori economici e finanziari considerati maggiormente responsabili in Italia del ritardo sul clima
Si può ancora centrare l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di fine 2015 sul contenimento dell’aumento delle temperature? A dirlo sarà la Cop30 di Belém. Ma insieme a questa, bisogna porsi un’altra domanda: chi ha remato contro in questi dieci anni, cioè ha continuato a spingere sui combustibili fossili che andrebbero invece consegnati alla storia il prima possibile?
Lenti puntate sui “soliti noti”
La risposta è nel rapporto “Dieci anni perduti. Come i protagonisti dell’estrattivismo fossile italiano hanno minato l’Accordo di Parigi”, pubblicato oggi da ReCommon. Dove sul banco degli imputati ci sono un po’ i soliti noti. Quelli cioè che una sfilza di indagini in Italia e nel mondo mettono da anni sotto la lente, ovviamente criticandoli. Mentre per i media mainstream restano i “campioni nazionali” di cui non si può che dir bene, signora mia.
Stiamo parlando delle corporation fossili e degli attori della finanza pubblica e privata che da anni ReCommon ha messo nel mirino delle sue campagne. Eni e Snam sul lato corporation, ricordando che proprio verso Eni ReCommon insieme a Greenpeace e a dodici cittadini italiani ha avviato la prima climate litigation nel nostro Paese contro una società privata, che ha poi portato allo storico pronunciamento della Cassazione che ha definitivamente spianato la strada alle cause climatiche in Italia. Sul lato finanziario, SACE e Intesa Sanpaolo.
Il peso di Eni e Snam sull’Accordo di Parigi
Il rapporto sottolinea come dalla Cop21 Eni ha prodotto in totale circa 6,39 miliardi di barili equivalenti di petrolio e gas. E ogni anno la più grande multinazionale italiana ha dichiarato la volontà di aumentare la produzione di combustibili fossili almeno fino al 2030. Una produzione che secondo il rapporto porterà Eni a sforamenti del 73% (2024) e dell’89% (2025) rispetto agli scenari “net zero” delineati già nel 2021 dall’Agenzia Internazionale dell’Energia per raggiungere l’obiettivo degli 1,5 °C. Per giunta nella Global Oil & Gas Exit List appena pubblicata, a cui ReCommon ha contribuito, la società guidata da Claudio Descalzi figura al 13esimo posto nella classifica delle major mondiali dell’oil&gas con piani di espansione.
Snam in questi ultimi anni è diventata il più grande operatore in Europa della rete di trasporto del gas per infrastrutture controllate: oltre 40mila chilometri di gasdotti, terminal di rigassificazione per 28 miliardi di metri cubi di capacità annua gestita, depositi di stoccaggio per 16,9 miliardi di metri cubi.
Il report ricostruisce il modo in cui Snam e altre grandi TSO in Europa (Transmission System Operator) da una parte hanno saputo cavalcare il momento, cioè approfittare del fatto ad esempio che l’Ue ha designato il gas (che è una fonte fossile) come il “combustibile di transizione” per eccellenza, o degli appelli alla “sicurezza energetica” (ovviamente col gas) dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.
Dall’altra, queste società hanno investito pesantemente in attività di lobbying: 900mila euro per esercitare pressione a Bruxelles nel solo 2018, con quasi 50 incontri coi funzionari della Commissione Ue. Tra fine 2019 e 2020, sono stati invece 163 incontri gli incontri di Snam, di altre aziende e gruppi di pressione, coi Commissari europei per discutere di energia. In sintesi, denuncia il rapporto, con un piano di investimenti via l’altro Snam ha continuato a investire nell’espansione del business legato al gas fossile.
La finanza, Intesa Sanpaolo e Sace
È proprio l’operatività di SACE, dice il rapporto, a fare dell’Italia il primo finanziatore pubblico dell’industria fossile in Europa e il quarto a livello globale: tristi primati. Negli ultimi dieci anni SACE ha rilasciato garanzie per il settore dell’energia fossile superiori ai 22 miliardi di euro.
Alla Cop26 di Glasgow, nel 2021, l’Italia aveva sottoscritto la cosiddetta “Dichiarazione di Glasgow”, impegnandosi a mettere uno stop entro fine 2022 al sostegno pubblico diretto a progetti fossili internazionali. Ma la policy climatica resa pubblica da SACE nel 2023 consente all’Italia, sottolinea il rapporto, di sostenere con soldi pubblici il comparto dell’energia fossile praticamente per sempre: solo nel biennio 2023-2024 SACE ha rilasciato garanzie per almeno 15 operazioni legate all’energia prodotta da combustibili fossili.
Infine Intesa Sanpaolo, il più grande gruppo bancario privato italiano. Che già non brilla, diciamo così, nei report dei watchdog internazionali che periodicamente mettono alla berlina la finanza fossile. Nel 2024, ricorda il rapporto, i finanziamenti a carbone, petrolio e gas sono aumentati per la banca del 18% sull’anno precedente, toccando gli 11 miliardi di dollari, e gli investimenti sono saliti del 16%. La corporation fossile più finanziata da Intesa Sanpaolo è Eni, ma è cresciuto anche il sostegno a finanziario a Snam: tutto si tiene.
«Chi ha maggiori responsabilità, paghi i costi della crisi»
Nella lotta alla crisi climatica si dice spesso, ed è verissimo, che ogni frazione di grado conta. Si dice anche, ed è sempre vero, che non c’è da perdere un secondo per mettere in campo ogni azione possibile per tentare di evitare almeno gli impatti più catastrofici derivanti dal clima impazzito. Ma qui stiamo parlando di dieci anni, che secondo il rapporto di ReCommon sono stati sostanzialmente perduti.
«Quando si parla di crisi climatica – è il commento di Simone Ogno, campaigner finanza e clima di ReCommon – c’è chi ha maggiori, incomparabili responsabilità rispetto al singolo individuo: i gruppi industriali e finanziari. È arrivato il momento che i responsabili siano in prima fila a pagare i costi di questa crisi».

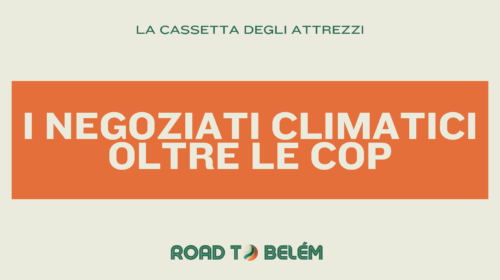
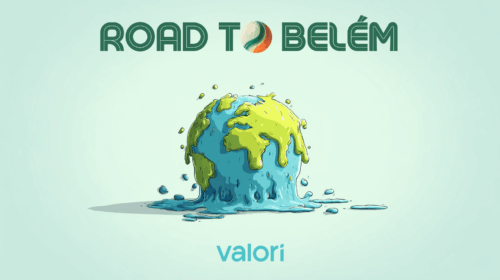

Nessun commento finora.